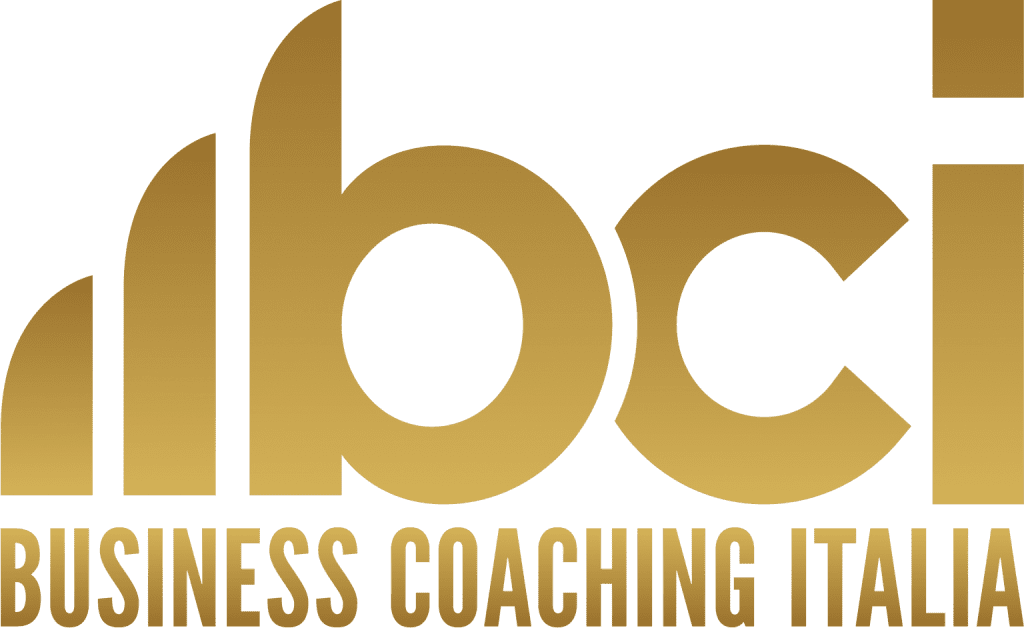Nella terminologia adottata da O. Williamson, economista statunitense e premio Nobel proprio per questa categoria, la macrostruttura polifunzionale è caratterizzata da più livelli di gerarchia, che vendono al vertice l’alta direzione, seguita dalle direzioni di funzione, dalle unità operative e dagli organi di staff e il decentramento selettivo del potere decisionale verso le direzioni di funzioni.
Lo schema più diffuso nell’organizzazione aziendale risulta proprio questo, perché sembra essere efficace per piccole, grandi e medie imprese, senza distinzioni specifiche e valido per qualsiasi tipologia di attività.
Tuttavia, la macrostruttura polifunzionale sembra essere particolarmente adatta a realtà i cui prodotti godono di una sperimentazione e una standardizzazione su vasta scala, in cui l’innovazione tecnologica non è attivamente presente (o comunque non rappresenti il core business dell’azienda) e, di conseguenza, l’assetto principale non deve essere periodicamente riequilibrato o modificato in base ai relativi cambiamenti di tecnologie. Infine, è adatto anche per realtà con ridotta variabilità ambientale.
Ma, oltre ai vantaggi, la macrostruttura polifunzionale presenta anche alcuni limiti strutturali, a partire dalla comunicazione interna, che risulta molto più rallentata (rispetto magari al livello di macrostruttura divisionale). In secondo luogo, la difficoltà a far fronte alla variazione sia ambientale, sia tecnologica per i motivi sopraelencati e la tendenza degli attori organizzativi, a elaborare dei sotto-obiettivi, naturalmente limitati alla loro funzione specifica, perdendo di vista però l’obiettivo generale e lo scorrimento stesso di tutti i processi aziendali.